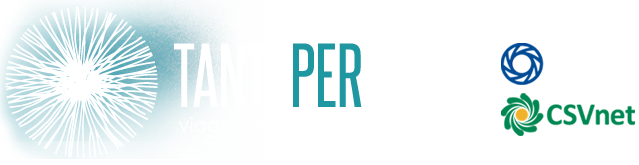“Immagine MDVI”, di Emilio Vendramin

Per quasi due anni, dal 2013 al 2014, il fotografo anconetano Emilio Vendramin ha seguito e fotografato il Progetto Europeo “IMAGINE MDVI” (Inclusive forum to develop Movement, Action, Gesture, Improvisation, Negotiation and Expression of Multiple Disability Visual Impairment adults), nato per sviluppare – attraverso la cultura del teatro – le abilità di adulti con menomazione visiva e disabilità multipla. In questo progetto, che vede coinvolte anche Germania, Scozia e Francia, l’Italia è impegnata e rappresentata attraverso la Lega del Filo d’Oro.
Attilio Lauria
- Cos’è che ti ha spinto ad interessarti del volontariato?
E’ una scelta che viene da lontano e, almeno nel mio caso, nasce dall’essere stato, e sono tutt’ora in alcune occasioni io stesso un volontario. Un volontario non può affidarsi solo alla buona volontà, ma deve avere competenze specifiche. Io ho trovato, nella fotografia, un mio ruolo. Ho messo a disposizione le mie conoscenze e le mie esperienze. Ho trovato un modo soddisfacente di dare un senso al mio fotografare.
- Per evitare il rischio di una rappresentazione retorica o semplicemente celebrativa è necessario approfondire la conoscenza del mondo del volontariato: come ti sei preparato all’approccio con questa realtà?
Oltre ad alcuni interventi fotografici, continui e se vogliamo “marginali” che realizzo a favore di un’associazione che si prende cura di persone con gravi disabilità, in tre occasioni ho avuto la necessità di svolgere quelli che potrei definire lavori completi. Per brevità dirò solo che si è trattato di accompagnare una missione umanitaria nei campi profughi Saharawi, di realizzare un libro fotografico per l’Associazione Lega del Filo d’Oro e di documentare, per la stessa associazione, il lavoro svolto durante la partecipazione ad un progetto europeo relativo alle attività teatrali svolte da persone altamente disabili. Nel primo di questi casi, si trattava di una missione di tre settimane nelle tendopoli situate ai confini fra Algeria e Mali. Se sbagliavi una foto non potevi rifarla il giorno dopo. Così ho cercato di documentami il più possibile su tutti gli aspetti. Soprattutto ho visionato tutte le immagini disponibili in rete in modo da non fare delle foto-fotocopia. Inoltre ho studiato la situazione storico politica dei Saharawi ed ho parlato con diversi volontari con cui avrei viaggiato. Negli altri due casi citati, la conoscenza pluriennale dei luoghi, delle persone e delle problematiche connesse al loro stato ha consentito un approccio più immediato. Chiaro che quando si entra in un mondo che non si conosce a fondo il primo passo è la conoscenza. L’approccio cui mi riferisco ha riguardato anche i volontari che sarebbero comunque entrati nelle immagini ma, soprattutto, che conoscevano la realtà dall’interno. Si è trattato di un lungo percorso di avvicinamento e di trasferimento di informazioni unidirezionale – da loro a me – che è terminato quando, come potevo verificare, ero diventato invisibile, come fotografo, agli occhi di tutti. Parlando dei tempi aggiungo che per il libro Campioni i tempi fotografici sono stai di circa due anni, fotografando una volta alla settimana.
- Altre qualità necessarie immagino siano empatia e rispetto per i soggetti fotografati
Si tratta di due condizioni irrinunciabili. Nel momento in cui si decide di inquadrare, ovvero di inserire in un quadro definito una situazione, non ritengo sia possibile farlo efficacemente se non si è prima creato un rapporto biunivoco con i soggetti e con il loro contesto. Questo rapporto è fatto di comunicazione e di attenzione. E attenzione significa rispetto delle situazioni, dei singoli momenti. Rispetto che si manifesta anche scegliendo, in alcuni casi, di non fotografare. Le nostre città sono sempre più popolate da persone in evidente stato di difficoltà sociale. Altrettanto troviamo negli ospedali, nei rifugi e nei luoghi di accoglienza. Suggerisco di evitare la foto ad effetto del mendicante, del senzatetto. Personalmente adotto questo comportamento quando il risultato, che pure potrebbe essere fotograficamente valido, perde la sua principale caratteristica: essere utile non solo all’autore.
- Si riesce ad essere testimoni neutrali nel realizzare un reportage di questa natura, o si rappresenta comunque il proprio punto di vista?
Il semplice fatto di decidere la realizzazione di progetti ad ampio respiro sociale è già, almeno per me, una presa di posizione. Per approfondire questo aspetto , piuttosto che farlo con parole mie, suggerisco la lettura di “Un comportamento irragionevole”, autobiografia di Don McCullin. Non è un libro fotografico, non parla di fotografia, ne di fotocamere o di obiettivi, forse volutamente. Ma l’aspetto umano è il suo forte. E’ l’autobiografia di un uomo che ne ha viste di tutti i colori, che ha grande compassione per emarginati e derelitti, soprattutto bambini. Appunto la compassione, unita alla conoscenza, deve il fotografo mettere nella sua borsa.
- Di questa esperienza umana ancor più che fotografica ti è rimasta impressa qualche storia in particolare?
Nell’ottobre del 2004 ho accompagnato, in qualità di fotografo volontario e non retribuito – tengo molto a sottolineare questo aspetto – una missione umanitaria nei campi profughi Saharawi. Un giorno, fuori di una scuola che avevo visitato, aspetto che i bambini escano per fare qualche scatto. Si sa i giovani sono irruenti e sono usciti tutti assieme, in un attimo. Per abitudine – utilizzo una Leica M6 ed avevo montato un obiettivo 35 mm – avevo la macchina già impostata con il tempo di scatto giusto e l’obiettivo regolato per lavorare in iperfocale. Allora, i ragazzi escono correndo, mi vedono, vengono verso di me incuriositi, guardo nel mirino per aggiustare l’inquadratura e mi accorgo di essere troppo vicino. Faccio un passo indietro e … scattando cado in una buca. La foto comunque è venuta fuori. Come si lega questo piccolo episodio al tema del volontariato? Semplice. Non solo hanno riso i bambini, ma lo hanno anche fatto, di cuore, i volontari italiani, svizzeri, americani e spagnoli che erano con me.
- Dal punto di vista del linguaggio fotografico diversi lavori ricorrono ad una grammatica fatta ad esempio di luci e ombre incise per dare forza alla rappresentazione, o all’esasperazione drammatizzante dei contrasti, cosa ne pensi?
Il linguaggio fotografico è una caratteristica personale. E’ qualcosa che sta dentro di noi, che nasce dalla nostra cultura, dal personale vissuto. Se una foto funziona o no lo si capisce dalla luce che si accende, o non si accende, negli occhi dell’osservatore/fruitore del nostro lavoro. Più in generale credo – ma questa è solo una mia convinzione personale – che fotografando non trasmettiamo “qualcosa” con le nostre immagini ma, piuttosto, enunciamo “qualcosa” sperando che i fruitori delle nostre nostre immagini leggano e comprendano le nostre sensazioni. La fotografia, intesa come prodotto finito, è un segno del linguaggio e come tale stabilisce una relazione strutturale fra significante e significato. Su questo argomento sono state scritte pagine su pagine e sarebbe bene che se ne fossero lette almeno alcune prima di iniziare qualsiasi lavoro. Sempre a proposito di linguaggio fotografico, per il quale esistono precise leggi codificate, se uno studio delle ombre e delle luci è sicuramente importante, non ritengo tuttavia che si tratti di una condizione determinante. Una buona immagine nasce sempre da un’attenta osservazione della realtà, unita ad un’idea chiara e fondante di cosa si vuole ottenere. In questo quadro generale ritengo – almeno io faccio così – che sia il fotografo a doversi adeguare alle condizioni in cui si trova ad operare. E con questo intendo anche suggerire una completa conoscenza delle possibilità e dei limiti dell’attrezzatura di cui si dispone. Luci bruciate, contrasti netti, ombre chiuse sono elementi che possono essere suggestivi ad un primo sommario esame ma nulla aggiungono ad una fotografia. Di più eliminano informazioni che, se correttamente gestite nella fase di post produzione, aumentano il valore comunicativo di una fotografia. Potrebbe forse essere utile, a questo proposito, ripassare, soprattutto per chi usa il bianconero, alcuni concetti ben espressi da Ansel Adams quando parla della scala tonale.
- C’è spazio secondo te per lavori concettuali, oltre il reportage documentario?
Ho difficoltà a definire un lavoro fotografico come concettuale. O meglio ho difficoltà a non definirlo tale. Ma se la domanda vuole evidenziare una sorta di “scala gerarchica” direi che lo spazio c’è. Immagino che il documentario possa limitarsi a documentare, appunto, una situazione, mentre un lavoro fotografico più complesso potrebbe condurre l’osservatore/fruitore delle immagini ad una migliore conoscenza di una determinata situazione e spingerlo a cercare soluzioni adeguate e percorribili del problema trattato. Ecco, sempre sottolineando che in entrambi i casi l’approccio conoscitivo è propedeutico all’azione del fotografare, lo spazio c’è.
- Immaginiamo di essere in un tuo workshop, quali consigli ti sentiresti di dare ai nostri lettori?
Non ritengo di avere il back ground necessario per dare consigli, ovviamente. Non è falsa modestia ma valutazione realistica delle proprie capacità. E questo credo possa essere il primo consiglio. Una volta definito il progetto, prima di passare alla fase engineering, eseguire una attenta – e soprattutto intellettualmente onesta – autovalutazione delle proprie capacità e dei propri limiti. Inutile pensare di attraversale l’oceano a nuoto se non sappiamo nuotare. Altro aspetto da considerare è l’approccio con una associazione di volontariato. Presentarsi come persona disposta prima ad imparare e poi a fotografare. Un po di umiltà non guasta. E ancora esaminare tutti gli aspetti relativi alla necessità o meno di autorizzazioni, permessi, liberatorie; su questo ultimo aspetto la legislazione vigente sulla c.d. privacy è piuttosto complessa e conviene sapere da subito cosa si può o non si può fare. Da ultimo, ma non meno importante: viaggiate leggeri. Si tratterà comunque di fotografie realizzate in un contesto “dinamico” dove una fotocamera ed un paio di obiettivi saranno più che sufficienti. Personalmente, ad esempio, le foto del mio libro Campioni sono state tutte scattate con una fotocamera digitale (Leica M8) ed un solo obiettivo (Elmarit 1:2,8/28mm). Se vi piacciono – o avete – degli obiettivi zoom usateli pure ma ricordate che, anche se avete solo il classico 50, bastano un passo avanti o uno indietro … (purtroppo questa pillola di saggezza non è farina del mio sacco, ma ne faccio costantemente tesoro).
- È questo il mondo possibile?
Penso proprio di si. Credo possa essere utile – per chiudere un discorso su un progetto dove, alla fine, i soggetti saranno dei nostri simili – citare Robert Doisneau: “Mi piacciono le persone per le loro debolezze e difetti. Mi trovo bene con la gente comune. Parliamo. Iniziamo a parlare del tempo e a poco a poco arriviamo alle cose importanti. Quando le fotografo non è come se fossi lì ad esaminarle con una lente di ingrandimento, come un osservatore freddo e scientifico. E’ una cosa molto fraterna, ed è bellissimo far luce su quelle persone che non sono mai sotto i riflettori.”
Tutte le foto © Emilio Vendramin, cortesia dell’Autore