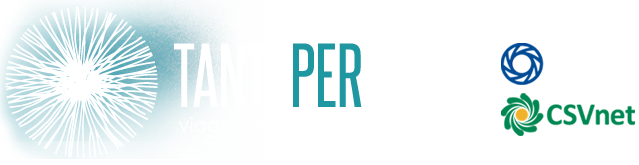“Refugees Housed Bibione”, di Alfredo Bini

“Refugees Housed Bibione” è un lavoro sulla colonia marina Pio XII di Bibione, Venezia, costruita dopo la guerra per ospitare le famiglie dei dipendenti di Pirelli, e gestita da un’associazione di volontari che – all’epoca del lavoro – accoglieva 50 africani in fuga dalla guerra libica, in attesa di ottenere un qualche tipo di status umanitario che consentisse loro di rimanere in Italia.
Attilio Lauria
Alfredo Bini è un fotogiornalista e regista freelance. Il suo lavoro è pubblicato sui maggiori media internazionali e presentato in musei, gallerie, università, conferenze e programmi televisivi.
“Transmigrations”, il suo progetto sul viaggio dei migranti attraverso il Sahara è stato pubblicato su African and Black Diaspora per la DePaul University di Chicago, e per l’Harvard University su New Geographies Journal. Ha vinto premi ed è stato presentato in festival e mostre personali in tutto il mondo.
“Libyan Uprising,” è un reportage sul primo mese della rivoluzione Libica del 17 Febbraio che include le prime immagini al mondo pubblicate dalla stampa internazionale sull’assedio di Misurata. È stato proiettato al New York Photo Festival 2011 e all’Auckland Festival of Photography 2012.
Land Grabbing or Land to Investors? È stato esposto e proiettato al 24° Visa Pour l’Image di Perpignan, al 12° China Pingyao International Photography Festival, e al 3° Brooklyn Photoville Festival. È stato recentemente prodotto un video documentario presentato in Italia durante il 25° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano e proiettato a Expo 2015 presso il padiglione Slow Food.
Lavora su progetti editoriali, corporate e pubblicitari. Il suo lavoro è rappresentato dall’agenzia Francese Cosmos. Vive tra l’Italia e gli Stati Uniti.
- Cos’è che ti ha spinto ad interessarti del volontariato?
Ho seguito la storia della colonia marina Pio XII di Bibione perché m’interessavano le vicende dei profughi che scappavano dalla guerra in Libia. Avevo coperto la rivoluzione del 17 Febbraio a Benghazi e Misurata e conoscevo bene le condizioni da cui provenivano i migranti che scappavano da quest’ultima città. Il Centro Italiano Femminile di Venezia gli accoglieva usando una struttura che un tempo giovava alle vacanze dei figli degli operai Pirelli. Mi sembrò una storia interessante e così con la giornalista Cecilia Ferrara decidemmo di raccontarla.
- Per evitare il rischio di una rappresentazione retorica o semplicemente celebrativa è necessario approfondire la conoscenza del mondo del volontariato: come ti sei preparato all’approccio con questa realtà?
Avevo già lavorato con associazioni di volontariato in Africa Occidentale e conoscevo il mondo della cooperazione internazionale e delle agenzie delle Nazioni Unite. Spesso le associazioni di volontariato s’inseriscono in programmi delineati da enti governativi o sovranazionali, per cui non è stato difficile capire e interpretare il modus operandi del Centro Italiano Femminile.
- Altre qualità necessarie immagino siano empatia e rispetto per i soggetti fotografati
Quello dovrebbe valere sempre. Il rispetto per il soggetto è imprescindibile e permettere d’interpretarlo evitando facili stereotipi.
- Si riesce ad essere testimoni neutrali nel realizzare un reportage di questa natura, o si rappresenta comunque il proprio punto di vista?
Si prendono sempre le parti in qualsiasi reportage si realizzi. L’abilità sta nel capire quale sia quella “giusta” nel senso più umanista del termine.
- Di questa esperienza umana ancor più che fotografica ti è rimasta impressa qualche storia in particolare?
Sono entrato in contatto con le prime storie di migrazione nel 2006, e nel 2009 mentre realizzavo Transmigrations, 4000 migranti mi scortarono lungo il deserto del Sahara fino al confine meridionale Libico, dove li lasciai per l’impossibilità di continuare il viaggio con loro. Quando la rivoluzione contro Gheddafi iniziò a far vacillare il regime, mi sembrò una buona opportunità per entrare in Libia e ripercorrere qualcuna delle storie che avevo seguito due anni prima. Sfortunatamente la sommossa virò presto in una guerra fratricida rendendo impossibile muoversi liberamente, così cambiai lo scopo del viaggio e la raccontai. Lasciai la Libia su un peschereccio che faceva la spola da Malta a Misurata e che era usato per consegnare aiuti ai ribelli. Fummo i primi giornalisti occidentali a metter piede in una città che era sotto assedio da più d’ottanta giorni. Quando s’è presentata l’opportunità d’intervistare e fotografare dei migranti che avevano fatto il mio stesso percorso, ovviamente da una posizione molto meno privilegiata, ogni storia che ascoltavo mi ricordava le scene che avevo visto durante Transmigrations. Due di queste storie non sono riuscito a fotografarle e riaffiorano spesso nei miei ricordi.
-L’espressione del ragazzo caduto da qualche camion in pieno deserto, a 50 km da Agadez, che s’inginocchia al lato della pista implorando lo chauffeur di fermarsi a raccoglierlo. Eravamo l’ultimo mezzo alla fine del convoglio e l’autista non si fermò.
-La festa che i 4000 migranti fecero la sera stessa e che continuò per tutta la notte nell’oasi di Turawet. Euforici per essere riusciti a partire, iniziava la loro avventura. Giovani, incoscienti e sognatori festeggiarono fino all’alba tra canti e balli della loro terra.
- Dal punto di vista del linguaggio fotografico diversi lavori ricorrono ad una grammatica fatta ad esempio di luci e ombre incise per dare forza alla rappresentazione, o all’esasperazione drammatizzante dei contrasti, cosa ne pensi?
Che non c’è niente da pensare. Il linguaggio fotografico è un mezzo per mostrare la condizione umana e non mi soffermo troppo sulla forma. M’interessa la storia! Lo scopo della fotografia di reportage è di rappresentare questa condizione possibilmente svelando in modo giornalisticamente ineccepibile storie che meritano d’essere conosciute e approfondite. Tutto il resto è secondario, e disquisire di linguaggio è inversamente proporzionale alla mancanza d’argomenti sul contenuto. Non dico che non è importante. Il linguaggio fotografico è fondamentale, ma per me deve restare subordinato alla potenza narrativa della storia che si racconta.
- C’è spazio secondo te per lavori concettuali, oltre il reportage documentario?
Si ma valgono i punti di cui sopra. Gran parte della fotografia concettuale che si produce oggi è banale ed egoriferita, oltre che pleonastica dal punto di vista documentale. Pretende d’esprimere un concetto di cui spesso solo l’autore e il gallerista ne conoscono i significati, sovente senza riuscire nemmeno a spiegarli comprensibilmente. La sua popolarità è direttamente proporzionale al decrescere della preparazione di chi oggi tratta di fotografia ed è molto utile alle costose scuole private che con la crisi della fotografia commerciale, non sapendo dove parare, la propinano come rimedio per risolvere il problema autoriale. Quel problema si risolve solo con la cultura, lo studio, la conoscenza e la passione. Indipendentemente dal linguaggio fotografico che si sceglie, il lavoro sarà tanto più efficace e duraturo tanto più s’affronterà preparati il soggetto.
- Immaginiamo di essere in un tuo workshop, quali consigli ti sentiresti di dare ai nostri lettori?
Esattamente quello che ho detto finora. La fotografia è un mezzo per esprimersi, possibilmente in un modo che sia comprensibile a tutti. Qualsiasi forma d’arte raggiunge il suo scopo quando parla a chiunque e non è diretta a una specifica platea. A questo proposito vorrei citare la riflessione d’un caro amico architetto, che dopo una visita al cimitero Brion, progettato da Carlo Scarpa scrisse queste note sul suo blog:
“le opere d’arte e d’ingegno davvero meritevoli di questo nome hanno una voce per chiunque. Ognuno si sente sussurrare quel che han da dire e hanno una parola perfetta per ognuno. Un’opera meravigliosa e perfetta come questa ha molteplici livelli di lettura: dal più intellettuale al più spirituale al più umano. Semplicemente parla a chiunque lo visiti….”
- È questo il mondo possibile?
No! Molto presto la fotografia come l’abbiamo conosciuta noi non esisterà più, e stanno cambiando profondamente anche le piattaforme di fruizione dei contenuti giornalistici. Passo molto tempo negli Stati Uniti e chi vive di fotografia nel paese che detta le tendenze comunicative dal dopoguerra ad oggi, lo fa attraverso la fotografia commerciale e il visual storytelling, che trova nello scrollytelling la rappresentazione narrativa attualmente più ordinaria. Ovviamente non considero in quest’analisi il mercato delle gallerie che ha tutt’altri schemi commerciali e divulgativi.
Personalmente sono attratto da linguaggi meno moderni e sono sempre più convinto che mai come oggi il mondo avrebbe bisogno d’un informazione meno sensazionalista, più riflessiva e approfondita. Qualcosa che parli all’anima delle persone piuttosto che ai loro impulsi, risvegliando sensi che da troppo tempo il giornalismo sembra non esser più capace di stimolare. Quando parliamo di fotogiornalismo ci rifacciamo a un modello narrativo che negli anni 60 e 70 provocò profondi cambiamenti nella società, ma perché culturalmente quel mondo non esiste più, quella comunicazione non è più efficace. Chi non ne prende consapevolezza resiste a una tendenza inarrestabile e anche se credo che mai come adesso ci sarebbe bisogno d’informare le persone con storie e linguaggi che stimolino riflessioni approfondite, i modelli comunicativi attuali non possono essere ignorati.
Tutte le foto cortesia dell’Autore
- Italy - Bibione (Venice). Marine colony Pio XIII. Built after the war for the families of Pirelli employees, it is now used as a welcome centre for the refugees from the Libyan war. Coming from Gambia and Nigeria some of them try to obtain the official status of refugee. The details of the asylum applications are examined by a commission which on average emits a negative decision in 90% of cases.
- Italy - Bibione (Venice). Marine colony Pio XIII. Foday Ceesay, 25 years old. He flees from Gambia in 2007 after he and a member of his family are threatened by exponents of the opposition party. He spends five months in prison in Libya where he then starts work as a carpenter. At the beginning of the war his father is killed during the disturbances in Tripoli while he himself manages to get to the port and onto a boat sailing to Lampedusa. “When the war broke out I thought Gheddaffi would stay in power, but then it became clear that this would not be the case and I decided to leave.” 90% of the asylum applications presented to the commission are judged to be false.
- Italy - Bibione (Venice). Marine colony Pio XIII. Benedict and Idemudia are brother and sister from Nigeria. They were both enrolled at university, respectively business school and political sciences. After their parents’ deaths they leave and settle in Misrata. Idemudia marries a fellow Nigerina in January 2011. When the bombings intensify they decide to go to the beach in Misrata and get on one of the many boats that were heading for Italy.. “When the revolution broke out in Tunisia and then in Egypt we didn’t think it would get this far. We were sure that Gheddaffi would prevent any kind of uprising. Instead it started and in Misrata in a brutal fashion”.
- Italy - Bibione (Venice). Marine colony Pio XIII. A guest of the structure goes towards the dormitories.
- Italy - Bibione (Venice). Marine colony Pio XIII. Foday Ceesay, 25, studies Italian grammar before his interview with the commission that will decide upon his repatriation. He flees from Gambia in 2007 after being threatened, with a relative, by members of the opposition party. He spends 5 months in prison in Libya where he then starts work as a carpenter. At the beginning of the war his father is killed during the disturbances in Tripoli while he himself manages to get to the port and onto a boat sailing to Lampedusa. “When the war broke out I thought Gheddaffi would stay in power, but then it became clear that this would not be the case and I decided to leave.” 90% of the asylum applications presented to the commission are judged to be false.