Reportage sociale ed estetizzazione: una sintesi possibile?
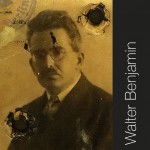
A proposito di problematiche linguistiche, e del “come” affrontare il nostro progetto, chi è che non si è interrogato almeno una volta di fronte alla “bellezza del terribile”? Cos’è, cioè, che ci crea una sensazione d’imbarazzo di fronte all’estetizzazione del reportage? Sarà forse perché nei documenti fotografici che testimoniano la sofferenza si vorrebbe tutto il peso della testimonianza senza la macchia dell’artisticità, percepita come una forma d’insincerità o come un inganno?
Attilio Lauria
È quanto ci siamo chiesti nel seminario di Bibbiena, a partire da una citazione di Susan Sontag, secondo cui “A dispetto della presunzione di veracità che conferisce autorità, interesse e fascino a tutti i fotografi, il loro lavoro non fa eccezione al consueto rapporto ambiguo della verità e arte. Anche quando si preoccupano soprattutto di rispecchiare la realtà, sono comunque tormentati dai taciti imperativi del gusto e della coscienza. (…) Anche se in un certo senso la macchina fotografica coglie effettivamente la realtà e non si limita a interpretarla, le fotografie sono un’interpretazione del mondo esattamente quanto i quadri e i disegni”. Dunque, “nonostante la finalità dichiarata da parte di una fotografia di rivelare la verità anziché la bellezza, la fotografia continua ad abbellire. Anzi il suo trionfo più duraturo è stata la capacità di scoprire il bello nell’umile, nel banale, nel decrepito.”
Amen!
A proposito quindi delle scelte linguistiche relative al “come” declinare il nostro progetto, non si può non tenere conto di quella tendenza (del fotografo, o della fotografia?) a trasformare tutto in “bello”, dalla miseria alla tragedia: scriveva Walter Benjamin nel 1934 che “[la macchina fotografica] è ora incapace di fotografare un casamento o un mucchio d’immondizie senza trasfigurarli. Per non parlare di una diga fluviale o di una fabbrica di cavi elettrici: di fronte ad esse, la fotografia può dire soltanto: “Come è bella”… Essa è riuscita a trasformare in oggetto di godimento persino la miseria più abietta”.
D’altra parte anche noi, da fruitori della fotografia, quando ci troviamo di fronte a un’immagine che ci attira, diciamo banalmente che è “una bella fotografia” oppure, estendendo il discorso a un progetto fotografico, che “è un bel lavoro”. Il che, oltre a rivelare la nostra pigrizia lessicale, è indicativo di quanto sia radicato il concetto di “bellezza” nel sentire comune.
“Hungry woman with her little child”, India, 1951, Werner Bischof, Magnum Photos, spesso citata come esempio di “miserabilismo”, altra declinazione del “documentarismo compassionevole”.
Volenti o nolenti, dobbiamo dunque fare i conti con la dialettica di forma e contenuto o, a seconda di come la si voglia dire, di significato e significante: come regolarsi?
Assodato che nella decisione di quale aspetto debba avere una fotografia ogni Autore impone sempre ai propri soggetti determinati criteri di carattere culturale e ideologico, ciò che può aiutarci nella decisione di delimitare il nostro confine estetico è la consapevolezza che oltre un certo limite – che sta appunto a noi individuare – l’esaltazione del contenuto estetico dell’immagine opera a discapito del messaggio documentale.
Ricorrere ad un linguaggio troppo estetizzante, che ricerca cioè un’empatia immediata, puntando più sull’emotività che sulla documentazione, rischia di dare importanza alla compassione a discapito dell’informazione, impedendo la comprensione e la collocazione storica del fenomeno che stiamo indagando.
“Broken Landscape”, Paolo Pellegrin
“Le immagini proposte in Broken Landscape sono incentrate su un sistema linguistico molto preciso. Enfatizzazione drammatica dell’inquadratura, uso evidentissimo di contrasti, cieli lividi, fortissima sgranatura del bianco e nero, angolazioni impressionanti. Si tratta di una tavolozza di segni che determinano un’architettura stilistica che si sovrappone in modo netto alla porzione di realtà prelevata dal fotografo.” Maurizio De Bonis
Secondo una nota teoria, che risale al saggio di Walter Benjamin “L’autore come produttore”, l’estetizzazione equivarrebbe ad un anestetizzazione: estetizzare il reale, perseguire cioè la bellezza fotografando la sofferenza significherebbe spingere alla contemplazione invece che all’indignazione e dunque all’azione. È così?
Affronteremo questo argomento in un prossimo post, partendo da Sebastiao Salgado, Autore spesso accusato di fare ricorso sistematico alla retorica della compassione.
Il 9 settembre 1991 il New Yorker riportava un articolo di Ingrid Sishy dal titolo “buone intenzioni” sul lavoro del fotografo brasiliano: “Salgado è troppo preso dagli aspetti compositivi delle sue immagini, dalla ricerca di grazia e bellezza nelle forme aberranti dei suoi soggetti sofferenti. Da questo indebolimento della tragedia ne derivano delle immagini che rinforzano decisamente la nostra passività rispetto all’esperienza che rivelano. Estetizzare la tragedia è il modo più rapido per anestetizzare i sentimenti di coloro che ne sono testimoni. La bellezza è un richiamo all’ammirazione, non all’azione.”
Leave a Reply
Devi essere connesso per pubblicare un commento.
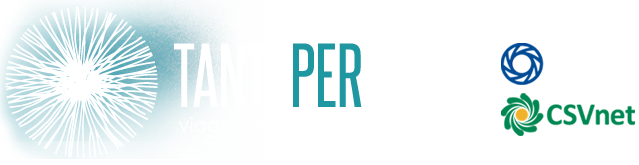






Attilio ci pone di fronte ad un bel dilemma…a mio parere non ci si deve sentire in colpa se una foto terribile e drammatica la percepiamo anche “bella”: l’efficacia di un fotografo di reportage sta nel produrre un’immagine che sappia toccare senza essere compassionevole, colpire senza cadere nel cattivo gusto, smuovere le nostre coscienze pur mantenendosi neutrale.La foto che soddisfa tutti questi requisiti è bella senza se e senza ma .
Mi vien da rispondere,e perchè no? Tutto è nella finalità che il fotografo si prefigge: personalmente tratto la disabilità per farla emergere dall’anonimato che spesso è una cortina impenetrabile,cercando di sottolineare l’aspetto ‘normale’ della vicenda,quasi nascondendo l’aspetto drammatico,senza per questo negarlo. E a questo punto mi sento anche libero di poter essere estetico,senza però voler stupire e in qualche modo spettacolarizzare,sarebbe troppo semplice. Innanzitutto viene la dignità,e quello è un bene di normodotati e disabili,che non va mai calpestato.
Penso sia così difficile trovare un giusto e sempre condivisibile equilibrio tra le due componenti che ognuno dovrà calibrare il proprio, in modo intelligente, dosando il tutto affinché una delle due parti non prevalga troppo sull’altra ma facendo in modo che lavorino bene in sinergia.
Forse sul concetto potremmo essere tutti d’accordo. Tradurlo in pratica sarà più complicato.
Penso che dobbiamo rassegnarci, o perlomeno devono rassegnarsi quei fotografi che vedono nel reportage un fedele strumento di documentazione: la fotografia, attualmente, non è il mezzo più adatto a riprodurre la realtà del mondo!
Il fotografo non può più essere solo l’operatore che documenta, ma (per fortuna) è venuto il momento di vestire i panni dell’artista che mostra la sua interpretazione della realtà che lo circonda.
E’ una questione storica: fino agli inizi dell’800 era la pittura l’unico mezzo deputato alla rappresentazione del mondo, poi la fotografia, con la sua incredibile possibilità di fermare l’attimo, entusiasmò gli animi (e la pittura poté orientarsi verso territori più concettuali).
Ora, finalmente, anche la fotografia ha la possibilità di liberarsi dalla pesante incombenza di dover documentare la realtà lasciando questa prerogativa alle riprese video (a due o tre dimensioni oltre alla dimensione temporale).
Ed è proprio dai limiti intrinseci alla fotografia che scaturisce la sua artisticità, primo fra tutti l’inquadratura che ci restituisce solo una piccola parte della realtà e, più che mostrare, nasconde.
La scelta di cosa mostrare sarà pertanto il primo passo nella nostra interpretazione della realtà e, nel caso dei lavori per il Progetto “TpT”, penso che l’attenzione dovrà focalizzarsi sull’azione del volontario, i suoi gesti o anche sulle sole tracce del suo operato senza cadere nell’errore di spostare l’emotività dello sguardo sui destinatari dell’azione del volontariato.