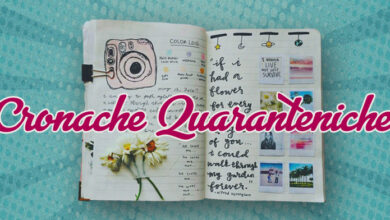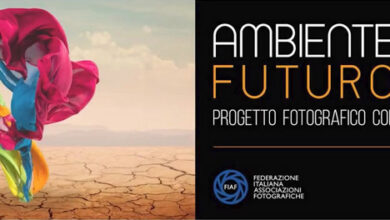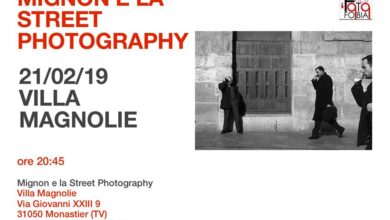Il 14 novembre ricorre un anno dalla scomparsa di Valentino Bassanini, fotografo sensibile e mio carissimo amico. Voglio ricordarlo qui, per farvi scoprire un autore di cui – ne sono certa – vi innamorerete.
Nato a Milano nel 1936, Valentino è una figura centrale, anche se in penombra, della fotografia italiana del secondo Novecento. Pittore per formazione e fotografo per vocazione, attraversa la scena milanese con uno sguardo discreto, curioso, mai invadente.
La sua storia comincia tra cavalletti e colori, alla Scuola di Brera e al Castello Sforzesco, dove si forma come pittore. Ma alla fine degli anni Cinquanta, mentre Milano entra nel vortice della modernità, sente che la pittura non basta più: il mondo si muove troppo in fretta per essere solo fissato su una tela.




La sua prima macchina fotografica, una Ikoflex 6×6 Zeiss, segna l’inizio di un lungo viaggio visivo. Con quella esplora i dintorni della città – la Brianza, le Alpi lombarde, i borghi dove la vita scorre lenta – ma presto il suo sguardo si rivolge a Milano, che sta cambiando volto. È lì, tra cantieri, periferie e nuovi ritmi urbani, che trova la sua ispirazione.
A metà degli anni Sessanta, insieme a Ernesto Fantozzi, Mario Finocchiaro, Gualtiero Castagnola, Giovanni Rosa e Carlo Cosulich, fonda il “Gruppo 66 – Ricerche e documentazioni fotografiche sulla città di Milano”, un collettivo nato per reagire ai manierismi fotografici del tempo. Niente effetti, niente spettacolo: solo la realtà osservata con onestà.
Per Valentino la fotografia non è mai solo tecnica o estetica, ma un gesto di testimonianza. Non cerca il dramma, ma la verità nelle piccole cose: una processione di quartiere, un mercato, un cortile, una periferia che cresce. Ogni immagine è un frammento di vita che diventa racconto.
La sua Milano è quella del cambiamento, ma non ha mai toni epici né nostalgici. È una città quotidiana, fatta di attese, di passaggi, di persone comuni. Le sue fotografie si muovono in quella zona sottile tra documento e poesia, dove il tempo sembra rallentare.
Il suo bianco e nero è essenziale: le linee architettoniche dialogano con la presenza umana in composizioni sobrie, costruite con la precisione di chi è nato pittore.





Valentino non impone, non commenta: osserva. È un fotografo “presente ma invisibile”, che affida alla luce la responsabilità del racconto. Nelle sue parole, “la fotografia deve testimoniare con sincerità, senza cercare effetti”, c’è tutta la sua poetica: la coerenza, l’umiltà, il rispetto per ciò che guarda.
Durante il suo percorso, ha esposto in numerose collettive e ha ricevuto riconoscimenti importanti, tra cui la nomina ad AFIAP (Artiste de la Fédération Internationale de l’Art Photographique) nel 1965. Molti suoi scatti fanno oggi parte di archivi pubblici e privati.
Una delle sue fotografie più note, “Lavaggio auto a Greco sul Naviglio della Martesana, Milano 1969”, è entrata nella monumentale “Storia d’Italia” pubblicata da Einaudi, nel volume degli “Annali 20. L’immagine fotografica 1945-2000″, e resta una delle immagini più poetiche della città. Ne possiedo una stampa, che Valentino mi regalò anni fa: è appesa nel mio soggiorno. Guardarla è come ritrovare il suo sguardo: discreto, partecipe, profondamente umano.





Il suo modo di fotografare non aveva bisogno di esibizione: invitava a rallentare, a osservare, a riconoscere la bellezza nascosta nelle cose comuni.
Nel suo lavoro convivono memoria, rigore e umanità. È stato un testimone vero, di un tempo in cui la fotografia serviva a capire, non a consumare.
Oggi, in un mondo dominato da immagini rapide e distratte, il suo sguardo ci ricorda che fotografare può ancora essere un atto di autenticità e di amore.




Lucia Laura Esposto